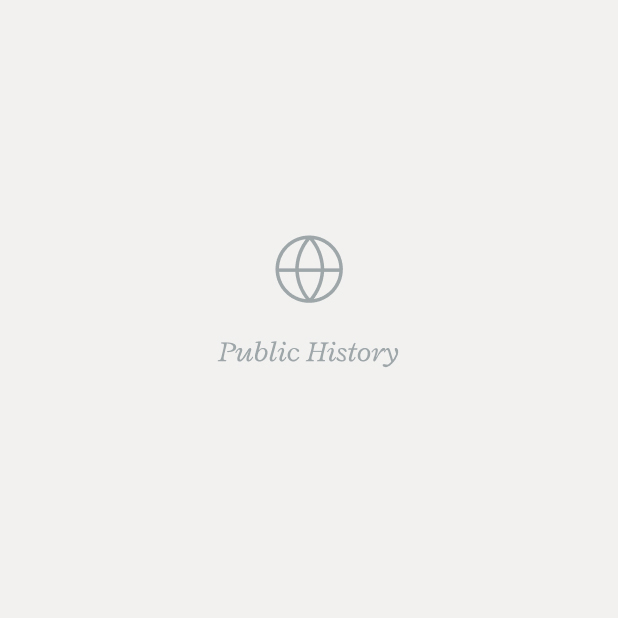
Benedetto Croce
Persona
filosofo
, Pescasseroli, L'Aquila / , Napoli
Biografia
CROCE, Benedetto. - Nacque a Pescasseroli (L'Aquila) il 25 febbr. 1866 da Pasquale e Luisa Sipari, di famiglia abruzzese i cui titoli di proprietà risalivano al sec. XVII. Il nonno Benedetto (1794-1854), magistrato borbonico, era stato consigliere presso la Suprema Corte di giustizia in Napoli.
Fu educato a Napoli: iscritto a nove anni al collegio della Carità, proseguì gli studi al liceo Genovesi. Nel 1883 si trasferiva a Roma nella casa dello zio Silvio Spaventa, divenuto tutore suo e dei fratello Alfonso, dopo la morte dei genitori e della sorella nel terremoto di Casamicciola di quell'anno. Si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza e segui con scarso profitto solo i corsi del primo anno, in particolare quelli del Filomusi-Guelfi. L'anno seguente prese a frequentare le lezioni di filosofia morale di Antonio Labriola, che aveva conosciuto nella casa dello zio Silvio, in via della Missione, luogo di incontro del mondo politico, intellettuale e giornalistico della capitale.
Nel 1886, senza pensare più alla laurea, che non prese mai, tornava a Napoli. Fin dagli anni dei liceo aveva inclinazione per gli studi eruditi e letterari, di cui sono testimonianza i primi scritti Pubblicati dal 1882 (Pagine sparse, 2, 1, 1943) che aveva proseguito nel soggiorno romano lavorando soprattutto alla Biblioteca Casanatense. A Napoli il C. entrò nel fiorente ambiente di eruditi e studiosi della Società storica, allora presieduta da Bartolomeo Capasso, legandosi di profonda amicizia col De Blasiis, S. Di Giacomo e M. Schipa.
Prendono inizio in questi anni gli studi del C. sul 1799 che, accresciuti da altri contributi nell'anno del centenario, vennero poi raccolti ne La rivoluzione napoletana del 1799: biografie, racconti, ricerche (1899), e sulla storia culturale e politica dell'Italia meridionale dei periodo aragonese, in parte poi raccolti in Storie e leggende napoletane e in Uomini e cose della vecchia Italia e altre sillogi. Di questo periodo (1889-1891) è anche l'ampia monografia su I teatri di Napoli dalla Rinascenza alla fine del secolo decimottavo, di cui redasse anche una diversa edizione nel 1916.
Nel 1892, con S. Di Giacomo, il C. dava vita alla rivista Napoli nobilissima, che uscirà fino al 1906 (ebbe una breve ripresa negli anni 1920-22), volta a illustrare i monumenti storici ed artistici napoletani e a divulgare la conoscenza dell'arte antica meridionale. La rivista fu affidata per la redazione a Giuseppe Ceci, ed in essa il C. scrisse una messe di articoli, rubriche e note.
Ma il lavoro più maturo di questo periodo sono le ricerche raccolte successivamente nel volume su La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza (1a, ediz., Bari 1917). illustrazione di taluni aspetti della vita morale e civile dell'Italia nel Quattro-Cinquecento. Fu con quest'ultimo lavoro, opera ancora frammentaria, che si fecero più stringenti nel C. gli stimoli ad approfondire i problemi logici e metodologici della storiografia e ad orientare gli studi in quella direzione che diede il suo primo frutto con la memoria su La storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte letta nel 1893 all'Accademia Pontaniana, di cui era divenuto uno dei soci più attivi.
Questa prima inclinazione del C. per gli studi filosofici ebbe una svolta decisiva nel 1895, quando il Labriola, con cui i rapporti, stretti durante il soggiorno romano, non si erano mai interrotti, gli inviò il suo opuscolo In memoria del "Manifesto dei comunisti", che egli fece pubblicare presso la casa editrice Loescher, come in seguito altri scritti del Labriola. Ne derivò per il C. un forte impulso allo studio della filosofia e dell'economia e un interesse nuovo alla vita civile e politica. Fu un "appassionamento politico", in primo luogo per le dottrine socialiste, che lo fece entrare in rapporto con gli ambienti del socialismo italiano, ma che andò negli anni seguenti stemperandosi nel corso degli studi che intraprese sul marxismo, che lo portarono a scrivere su alcuni aspetti centrali di esso i saggi - poi raccolti nel volume Materialismo storico ed economia marxistica (1900) - che tra il 1896 e il 1899 aveva pubblicato, tra l'altro, su la Riforma sociale e su Critica sociale nonché ancora su Divenir social, collaborazione quest'ultima che diede origine ai suoi rapporti con Georges Sorel.
Sono questi anche gli anni in cui il C. venne sviluppando altri interessi di studio, segnatamente quello per l'opera del De Sanctis del quale si fece editore e su cui, rispondendo alle obiezioni dei critici, fra i quali il Carducci, pubblicò una prima memoria per la Pontaniana, Francesco De Sanctis e i suoi critici recenti (1898). "La filosofia ebbe da allora parte sempre più larga nei miei studi - ricordava il C. - anche perché in quel mezzo, distaccandosi alquanto intellettualmente dal Labriola che non sapeva perdonarmi certe conclusioni che io traevo dalle sue premesse, cominciò la mia corrispondenza e collaborazione. con il Gentile, che conobbi giovanissimo, ancora studente dell'università di Pisa, e che aveva pubblicato recensioni dei miei lavori intorno alla teoria della storia ed al marxismo" (Contributoalla critica di me stesso, in Etica e politica).
Nel 1899, a Perugia dove trascorreva l'estate, aveva anche stretto una duratura amicizia con Carlo Vossler, testimoniata dal Carteggio Croce-Vossler (1951), in cui troviamo il primo annuncio della fondazione de La Critica. E fu a Perugia nel '99 che prese a lavorare intorno a "un'Estetica e una storia dell'Estetica", di cui il il primo frutto fu la memoria per la Pontaniana, Tesi fondamentali di un'Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale (1900), che due anni dopo sarà seguita dall'opera fondamentale del sistema filosofico crociano l'Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale (1902).
Il primo numero de La Critica uscì nel gennaio 1903 dallo stampatore Vecchi di Trani. La rivista fu poi, dal 1906, edita a Bari da Giuseppe Laterza lungo quasi un quarantennio, fino al 1945. cui seguirà fino al 1952 la serie dei Quaderni della Critica, sempre sotto la direzione dei C., che si giovò della stretta collaborazione prima di Giovanni Gentile e Guido De Ruggero, poi di Adolfo Omodeo. Dall'incontro con Laterza, che risale al 1903, nacque uno stretto rapporto di amicizia e una intensa collaborazione di cui vanno ricordate le maggiori collane editoriali dalla "Biblioteca di cultura moderna", ai "Classici della filosofia moderna", fondati nel 1907, e agli "Scrittori d'Italia", iniziati nel 1910; infine alla serie delle opere del C. che prese forma dal 1908 con la terza edizione dell'Estetica (il C. aveva già pubblicato alcune sue opere in altra forma dal Laterza) nelle quattro partizioni de "la filosofia dello spirito", dei "saggi filosofici", degli "scritti di storia letteraria e politica" e degli "scritti varii".
Tra il 1903 e il 1915 il C. proseguì i suoi studi di storia letteraria e civile, con una vasta messe di saggi pubblicati su La Critica, tra cui vanno ricordati quelli poi raccolti ne La letteratura della nuova Italia, i cui primi due volumi uscirono nel 1914 e il terzo e quarto nel 1915 (gli ultimi due nel 1939 e nel 1940), i Saggi sulla letteratura italiana del Seicento (1911) e il lavoro su la Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono, scritti negli anni 1914 e 1915 e pubblicati successivamente ne La Critica, poi raccolti in due volumi nel 1921. Ma furono soprattutto gli anni in cui scrisse, dopo l'Estetica, le sue maggiori opere filosofiche che delineano il suo sistema di "Filosofia dello Spirito". Nel 1905 negli Atti dell'Accademia Pontaniana (XXXV, mem. I) uscivano i Lineamenti d'una logica come scienza del concetto puro, che aveva "una seconda edizione interamente rifatta" col titolo Logica come scienza del concetto puro nel 1909. Lo stesso anno pubblicava la Filosofia della pratica. Economia ed etica, e Wilhelm Windelband gli richiedeva, per una collana tedesca, una monografia sulla filosofia della storia che uscì a Tubinga nel 1915e coi titolo di Teoria e storia della storiografia nell'originale italiano nel 1917. Accanto a queste opere maggiori vanno, tra gli altri scritti, segnalati due volumi: il Saggio sullo Regel seguito da altri scritti di storia della filosofia (1909) che raccoglie tra l'altro lo studio critico pubblicato nel 1906 su La Critica dal titolo Ciò che è vivo e ciò ch'è morto della filosofia di Hegel, e quello sulla Filosofia di Giambattista Vico (1910).
Va, inoltre, ricordata, per il rilievo che essa necessariamente assume nella biografia intellettuale del C., la polemica che egli ebbe con Giovanni Gentile intorno all'idealismo attuale, con due scritti, pubblicati su La Voce (ottobre e dicembre 1913), raccolti col titolo Una discussione tra filosofi amici nel secondo volume delle Conversazioni critiche (1918).
Nel 1910 il C. ricevette, su proposta del ministro Sonnino, a cui l'aveva segnalato Giustino Fortunato, la nomina a senatore (21a categoria: censo). Il C. non aveva mai partecipato in modo diretto alla vita politica. Il '98 lo aveva visto, su posizioni liberali, solidarizzare pubblicamente con i socialisti e trovarsi poi in sintonia con le posizioni di Zanardelli e Giolitti. Si trovò piuttosto a svolgere un ruolo politico come uomo di pensiero, di cui per altro era pienamente consapevole, come mostrano i giudizi su "l'opera della Critica e i suoi collaboratori" nelle pagine da lui scritte ne La storia d'Italia dal 1871 al 1914 (pp. 255 ss.).
Non irrilevante, al di là delle numerose polemiche d'ordine accademico, di cui va ricordata quella del 1908 (pubbl. 1909) Il caso Gentile e la disonestà nella vita universitaria italiana, è la sua partecipazione alla vita civile ed amministrativa. Anche qui numerose le polemiche in difesa del patrimonio artistico, librario ed archivistico. Nel novembre 1900 aveva assunto l'incarico, che tenne per nove mesi, di amministratore delle scuole elementari e medie del comune di Napoli. Molto attiva inoltre, come abbiamo accennato, la sua partecipazione alle istituzioni culturali napoletane. Nel luglio 1914, per le elezioni amministrative del comune di Napoli fu presidente del "fascio dell'ordine", l'alleanza liberale, moderato-cattolica, contrapposta al "blocco" delle Sinistre.
Difese le posizioni "neutraliste" con articoli de La Critica e assieme a Cesare De Lollis su L'Italia nostra, organo dell'omonima associazione, con una polemica culturale molto ferma contro il dilagare della demagogia nazionalista, in difesa dell'unitarietà della cultura europea e del ruolo che in essa, in modo particolare, vi svolgeva quella tedesca di cui diede testimonianza nel volume Pagine sulla guerra poi ristampato col titolo di L'Italia dal 1914 al 1918 (1919) e di cui ulteriore documentazione trovasi nel primo volume dell'Epistolario (Napoli 1967).
Nel giugno del 1920 Giolitti, con cui non aveva mai avuto rapporti personali, lo chiamava a far parte del suo ultimo ministero come titolare del dicastero della Pubblica Istruzione. Si mosse in una congiuntura difficile, in contrasto con la burocrazia ministeriale, con scarse simpatie in quei settori del Senato che provenivano dall'insegnamento universitario e, alla Camera, con la diffidenza dei popolari e la scoperta ostilità dei socialisti e dei settori liberaldemocratici di ispirazione massonica che costituivano la maggioranza nella commissione parlamentare della Pubblica Istruzione, in cui il C. ebbe difficoltà a varare provvedimenti legislativi minori e si trovò poi respinto il progetto istitutivo dell'esame di Stato, su cui il governo intendeva far perno per riformare la scuola media. il progetto era stato elaborato da una commissione ministeriale alla cui presidenza il C. aveva chiamato Giovanni Gentile. Con le risultanze di questa commissione il dissenso del C. aveva riguardato soltanto l'obbligatorietà dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari, che egli non propose. La bocciatura parlamentare del suo progetto di legge sull'esame di Stato lo indusse a presentare le dimissioni a Giolitti, che le respinse prevedendo di lì a pochi mesi lo scioglimento delle Camere. Numerose le iniziative prese nell'ambito dei suoi poteri, tra cui vanno ricordati il trasferimento della Biblioteca nazionale di Napoli dal Museo in un'ala della reggia e la ripresa delle relazioni culturali con la Germania, con la restituzione degli istituti confiscati durante la guerra. Nel giugno del 1921, nell'assenza da Roma di Giolitti, portò a termine l'incarico di risolvere lo sciopero degli impiegati dello Stato.
L'atteggiamento del C. di fronte all'ascesa del fascismo, dopo la marcia su Roma, fu simile a quello di altri esponenti liberali. In una intervista dell'ottobre 1923 osservava: "nel fatto non esiste ora una questione di liberalismo e di fascismo, ma solo una questione di forze politiche. Dove sono le forze che possono, ora fronteggiare o prendere la successione del governo presente? Io non le vedo. Noto invece grande paura di un eventuale ritorno alla paralisi parlamentare del 1922" (Paginesparse, II, 1943, pp. 477 s.). "Non riuscivo, neppure per ipotesi e immaginazione, a raffigurarmi un'Italia che si rassegnasse a lasciarsi togliere la libertà per la quale aveva combattuto", noterà altrove (Nuove pagine sparse, I, p. 83)., che era una soverchia fiducia che la solidità liberale delle istituzioni statutarie potesse essere coniugata con una azione di restaurazione conservatrice guidata dal fascismo. "Un segreto istinto di ritrosia" (ibid., p. 83) gli fece tuttavia rifiutare tutti gli incarichi che gli vennero offerti. Nell'estate che seguì il delitto Matteotti passò decisamente all'opposizione. Tra la fine di aprile e i primi di maggio del 1925, per invito di Giovanni Amendola, scrisse e pubblicò il Manifesto degli intellettuali antifascisti, in risposta ad uno redatto da Giovanni Gentile e firmato da un gruppo di intellettuali fascisti.
Con pochi altri colleghi rimase al Senato quale oppositore del regime, recandosi, tra il 1929 e il 1934 a tutte le sedute, per votare contro le leggi liberticide. Nel 1929 prese la parola in Senato contro i patti lateranensi.
Pur nelle vicende impegnative dei primo dopoguerra e dell'avvento dei fascismo l'attività di pensiero e di studio dei C. continuò senza soste. Vero è che esse appartengono ad una stagione nuova, più determinata dall'impegno civile. "I miei lavori filosofici e storici, senza cessar di essere severamente scientifici" egli stesso osserva, "si mossero, con maggiore e più rapida corrispondenza che per l'innanzi, secondo le nuove esigenze che la coscienza morale poneva". Vanno innanzi tutto ricordate le tre storie, "ideate già prima della guerra", la Storia del Regno di Napoli (1925), la Storia d'Italia dal 1871 al 1915 (1928)e la Storia d'Europa dal 1815 al 1915 (1932) a cui nel 1929 si era accompagnato il volume su l'Etàbarocca in Italia. Accanto a queste opere di sintesi, continuarono numerosi i lavori di storia letteraria e civile, raccolti principalmente nelle due serie di Uomini e cose della vecchia Italia (1927), nei Nuovisaggi sulla letteratura italiana del Seicento (1931), nelle Varietà di storialetteraria e civile (1935)e nelle Vite di avventure, di fede, di passione (1936). Le opere filosofiche più importanti di questo periodo furono La poesia: introduzione alla critica e storia della poesia e della letteratura (1936)in cui riprendeva i temi già trattati nell'Estetica, e La storia come pensiero e come azione (1939), in cui invece riprendeva i temi trattati in Teoria e storia della storiografia. Di questo periodo vanno anche ricordati i saggi, tra cui gli Elementi di politica, raccolti nel volume Etica e politica (1931)e Il carattere della filosofia moderna (1941).
Il giudizio del C. sul deflagrare del conflitto mondiale fu quello di una "guerra di religione", in cui vedeva lo sbocco inevitabile dell'ascesa in Europa del nazifascismo. Dopo la caduta del regime fascista ebbe subito un ruolo eminente ponendo il problema dell'abdicazione di Vittorio Emanuele III e di una reggenza fino al referendum istituzionale. La preoccupazione del C. fu quella di garantire la continuità istituzionale con un rapido passaggio dal regime regio a quello dei partiti costituzionali. Si trovò in netto contrasto su questo punto con le autorità alleate, in particolare con quelle inglesi e con gli ambienti di corte e venne a trovarsi in una posizione mediana tra il governo Badoglio e i partiti dell'intransigenza istituzionale P.C.I., P.S.I. e P.d'A. Ebbe influenza determinante sul congresso antifascista di Bari (29 genn. 1944) e sulla posizione intermedia che ne uscì, di richiesta dell'abdicazione del sovrano e della creazione della giunta dei partiti antifascisti. Dopo l'arrivo di Togliatti e il ritiro della pregiudiziale istituzionale da parte dei comunisti (marzo 1944). le autorità alleate appoggiarono la linea che egli andava sostenendo dall'agosto 1943 assieme a Sforza, Tarchiani, Rodinò, De Nicola e altri. Con la rinuncia al trono di Vittorio Emanuele III e la luogotenenza si rese possibile la costituzione del secondo governo Badoglio (aprile 1944), con la partecipazione dei partiti antifascisti, nella cui definizione il C. ebbe un notevole ruolo di mediazione politica e del quale entrò a far parte come ministro senza portafoglio. Dopo la liberazione di Roma il C. entrò anche nel primo governo Bonorni, sempre come ministro senza portafoglio, dandone le dimissioni il 27 luglio seguente.
La posizione del C., continuò ad essere coerente con l'impostazione inizialmente data alla sua azione politica dopo il 25 luglio, solo che a cambiare profondamente fu il peso, e quindi il ruolo, delle forze in giuoco. Gli elementi di continuità dello Stato liberale, che egli aveva inteso riaffermare, dovevano essere coniugati con la nuova realtà delle forze democratiche e dei nuovi partiti di massa. Il C., che aveva assunto la presidenza del P.L.I., su molte idee guida entrò subito in collisione con le posizioni assunte dagli altri partiti. La questione dei poteri del C.L.N. lo trovò sulle posizioni negative e rigide del P.L.I. e così il conseguente atteggiamento verso il governo Parri nel novembre '45. Significativa è anche la sua posizione sui poteri della futura Costituente, da limitarsi strettamente alla redazione della nuova carta costituzionale, e la posizione assunta sulla legge elettorale con la costituzione, insieme con Bonorni, Einaudi, Nitti e Orlando, della Lega per la difesa delle libertà democratiche con la proposta, di contro alla proporzionale, del collegio uninominale. Era stato membro della Consulta e fu eletto alla Costituente nella lista dell'Unione democratica nazionale. Sarebbe intervenuto nel dibattito sul progetto di costituzione solo per pronunziarsi contro l'art. 7 che regolava i rapporti tra la S. Sede e lo Stato italiano. Intervenne ancora il 4 giugno 1947 portando il voto di fiducia del P.L.I. al terzo governo De Gasperi, sottolineando l'approvazione per "il ritorno alla prassi costituzionale di una maggioranza che governa e di una minoranza che conduce con metodo democratico l'opposizione" (Scritti e discorsi politici (1943-1947), II, p. 399); ancora il 24 luglio dello stesso anno si pronunziava contro l'approvazione da parte della Costituente del trattato di pace, giusta una difesa del principio di nazionalità di cui si era fatto interprete presso gli Alleati fin dall'indomani della caduta del regime fascista. Il 30 nov. 1947 dava le dimissioni da presidente del P.L.I. Nel maggio 1948 tornava al Senato come senatore di diritto: il C., riuscendogli ormai troppo stancante viaggiare, partecipò solo al voto del Senato per l'adesione italiana al Patto atlantico (luglio '49).
Dal '45 la sua partecipazione alla vita politica democratica per quanto intensa si fece dunque più mediata, come testimonia, del resto, la maggior parte dei suoi interventi e delle sue polemiche, centrate su ques tioni di principio e sulla delucidazione del significato storico e ideale delle questioni. Già nell'agosto '43 aveva chiesto la soppressione dell'Accademia d'Italia e presiedette al rinnovamento dell'Accademia dei Lincei. Nel febbraio 1947 fondava l'Istituto italiano per gli studi storici con l'aiuto di Raffaele Mattioli, chiamando a dirigerlo Federico Chabod.
Furono questi ultimi anni, di più intensa partecipazione politica, parimente operosi come testimoniano i volumi da lui pubblicati, dai Discorsi di varia filosofia (1945), alle Indagini su Hegel e schiarimenti filosofici (1952), a cui debbono aggiungersi i tre volumi dei Poeti e scrittori del pieno e del tardo Rinascimento (1945e 1952), i saggisu La letteratura italiana del Settecento (1948), e le serie degli Aneddoti di varia letteratura e delle Pagine sparse.
Il C. morì a Napoli il 20 nov. 1952.
L'attività filosofica e quella storico-politica del C. devono essere intese ed esposte, nel ricco svolgimento della sua vita, come un'unità, anche se molteplice e nel corso del tempo diversamente accentuata. L'occuparsi di storia (res gestae)e di storiografia - e la riflessione su di esse - diede al C. impulsi importanti per i suoi studi filosofici, ed ebbe un ruolo centrale nel suo pensiero filosofico, dall'inizio del Novecento fino alle sue opere ultime. Questo studio fu al tempo stesso un'importante premessa per le sue prese di posizione politica, specialmente rispetto al fascismo e divenne, in particolar modo nelle opere sulla storia d'Italia dopo l'unità e sulla storia d'Europa nel secolo decimonono, l'efficace espressione della opposizione intellettuale alla dittatura fascista. Già dallo schizzo autobiografico del C. del 1915 Contributo alla critica di me stesso (Etica e politica, quarta ed., 1956) e dalla bibliografia delle sue pubblicazioni del Borsari si può vedere che gli interessi storici, accanto allo studio della letteratura e dei suoi problemi, precedettero di più di un decennio i suoi intensi studi filosofici, e che doveva passare più di un altro decennio prima che la coscienza politica del C., finora poco sviluppata e manifestatasi solo occasionalmente, si profilasse e si impegnasse chiaramente nel dibattito sull'intervento dell'Italia nella prima guerra mondiale.
All'inizio quindi fu la storia ad affascinare il C., la storia come oggetto di erudizione letteraria, che però non è arida e antiquata, poiché riceve impulso dall'incontro del C. con la città di Napoli, la sua patria elettiva, con le sue testimonianze del passato e la sua gente, e che porta con sé un elemento di viva umanità e trova un punto di contatto anche nelle apparentemente insignificanti tradizioni popolari.
Espressione di questa fase di interesse umano per la storia sono le molteplici ricerche, all'incirca degli anni fra il 1882e il 1900, sulla topografia storica, sulle tradizioni popolari e sulla biografia e aneddotica dell'Italia meridionale e in particolare della sua città (Saggi sulla letteratura italiana del Seicento, 1911; La rivoluzione napoletana del 1799: biografie, racconti, ricerche, 1912; I teatri di Napoli dal Rinascimento alla fine del secolo decimottavo, 1916; La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, 1917; Storie e leggende napoletane, 1919; Aneddoti di varia letteratura, 1942; Pagine sparse, 1919-20; Nuove pagine sparse, 1949).
Con l'andar del tempo il C. non fu più soddisfatto di questo lavoro erudito sul passato e, stimolato anche dai suoi studi sul marxismo, si sentì sempre più spinto ad una comprensione più profonda della storia e in particolare allo studio del problema del rapporto con il passato dell'uomo che pensa e agisce nel presente. Una prima riflessione sistematica sulla storia si trova in una conferenza tenuta all'Accademia Pontaniana a Napoli nel 1893, La storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte (Primi saggi, 1927). La tesi del C. parte dal rifiuto della concezione positivistica ed edonistica dell'arte. In questo modo egli può respingere anche l'interpretazione positivistica della storia (historiarerum gestarum)come scienza nel senso di scienza naturale, senza per questo svalutare la storiografia ispirata a questa concezione. Sicché nel momento in cui il C. concepisce l'arte come un campo a sé stante, con gli stessi diritti, accanto alla scienza, cioè come "raffigurazione dell'oggetto nella sua concretezza", la collocazione della storia nel campo dell'arte significa la sua liberazione da quelle errate e per questo irrealizzabili aspettative di scientificità. Ma ciò significa allo stesso tempo non una svalutazione della storia, ma la sua autonomia all'interno del campo dell'arte, come "narrazione dei fatti", a differenza dell'arte, intesa in senso più ampio come rappresentazione generalmente indipendente dai fatti. Il C. difende in seguito quest'autonomia della storia nel saggio Il concetto della storia anche contro ogni tentativo di una sua interpretazione generale da parte di qualsiasi tipo di filosofia della storia (Primi saggi, 1927).
L'incontro, di grande importanza, del C. con il marxismo avvenne nel 1895 attraverso il suo maestro romano e amico paterno, Antonio Labriola (l'esposizione e documentazione fatta dal C. di questo incontro si trova nel saggio Come nacque e come mori il marxismo teorico in Italia (1895-1900) del 1937 raccolto insieme ai saggi contemporanei al dibattito sul marxismo nel volume Materialismo storico ed economia marxistica, 1900; cfr. anche A. Labriola, Lettere a Benedetto Croce.1885-1904, Napoli 1975. Per quanto riguarda l'importanza dei marxismo nello sviluppo della storiografia italiana cfr. Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono, 1921). Il significato di questo incontro per il C. sta nel fatto che esso risvegliò in lui, per la prima Volta, anche se per un breve periodo, un vivo interesse politico che riempi il vuoto di interiore scontentezza provato per le ricerche fatte fino ad allora, e che inoltre lo spinse a dedicarsi a studi di economia e ad arricchire la sua visione della vita e della storia attraverso concreti aspetti economici, sociali e politici. In relazione a questa ampliata esperienza egli sviluppò il suo giudizio sul marxismo, che però non gli diede risposta definitiva riguardo al problema che lo interessava, ma che tuttavia divenne, per l'ampliamento e l'intensificazione della problematica, una premessa fondamentale per l'elaborazione della sua filosofia sistematica. Il nucleo centrale dell'interpretazione dei marxismo, che il C. svolse in diversi saggi dal 1896 fino al 1902, Si può puntualizzare in tre domande: quale forza conoscitiva sta nella concezione marxista? Quali conseguenze per l'azione concreta derivano dal marxismo? Come si può definire in generale l'azione pratica? Il C. non trova la forza conoscitiva del marxismo né in una generale interpretazione della realtà, né nello sviluppo delle leggi storiche o in una filosofia della storia, ma in un arricchimento dell'umano sapere sui fenomeni economici e il loro legame con la vita umana.
Il marxismo, secondo il C., non si risolve in una motivazione scientifica del socialismo, neppure come premessa necessaria dell'azione politica. Esso è piuttosto l'espressione di una determinata convinzione e posizione etico-politica, in cui, in generale, sia pure con contenuto diverso, consiste il concreto impulso all'azione. Il marxismo ha quindi un carattere pratico e politico e si rifà in questo ad una determinata situazione storica. Se deve di nuovo influire sull'agire, esso deve essere ripreso con fede e convinzione intima, cosa alla quale il C. stesso fu disposto solo per brevissimo tempo. Alla fondamentale chiarificazione dell'azione, secondo il C., il marxismo non apportò alcun contributo. Il C. cercò dapprima questa chiarificazione piuttosto nell'economia pura, ma deluso da questa, si volse ben presto ai tentativi di chiarire la posizione dell'azione nell'ambito della propria filosofia dello spirito.
La critica crociana al marxismo significò, per la cultura italiana, un più stretto collegamento con le posizioni revisionistiche di Eduard Bernstein, di Georges Sorel e anche di Antonio Labriola. Dopo la seconda guerra mondiale il C., stimolato questa volta dal confronto con la Russia, e con i partiti a struttura marxista del proprio paese, riprese i suoi studi sul marxismo con accenti molto critici (Filosofia e storiografia, 1949).
All'inizio dei secolo, il C., sulla base dei suoi studi sulla essenza dell'arte e della storia, e animato inoltre dal dibattito sul marxismo, si accinse ad una fondamentale chiarificazione filosofica delle sue concezioni. Lo spunto gli venne ancora una volta offerto dal campo dell'arte. Nelle sue Tesi sull'estetica e, ancora più conseguentemente, nella sua Estetica egli intraprese il superamento della concezione naturalistico-empirico-edonistica e di quella intellettualistica dell'arte e della realtà, identificando in generale arte ed espressione, cioè espressione dell'individuale - intuizione -, e determinava l'arte come attività spirituale e teoretica autonoma rispetto alla logica come conoscenza dell'universale, interpretandola anzi come necessario fondamento di questa (Tesi fondamentali di un'estetica come scienza dell'espressione linguisticagenerale, in Attidell'Accademia Pontaniana, XXX[1900], Memoria III; Estetica come scienza dell'espressione e linguisticagenerale, 1902). L'espressione, che parte dalle impressioni come presupposti indispensabili, non è però la loro conseguenza necessaria, ma è un'attività umana che si sviluppa liberamente. Partendo dalla sua identificazione di arte ed espressione, il C. chiarificava e rafforzava la base filosofica del dibattito sul carattere delle opere d'arte come estrinsecazione dell'arte e della realizzazione della funzione, solo a loro assegnata, di stimoli fisici della riproduzione di unespressione estetica, base teorica, fra l'altro, della sua critica letteraria. L'ulteriore definizione dell'estetica porta il C. ad un abbozzo di interpretazione filosofica di tutta la realtà. Il C. distingue dall'espressione, cioè l'attività teoretica, il volere, cioè l'attività Pratica, che ha come base e presupposto l'attività teoretica. Egli suddivide i due campi, teoria e prassi, fra loro reciprocamente connessi, in altri due gradi: sull'espressione, in quanto fondamentale attività teoretica, che ha come contenuto l'individuale, si fonda l'attività logica, che tende alla conoscenza dei concetti, all'universale; l'attività pratico-economica, la volontà, l'azione, che tende generalmente al conseguimento degli scopi, costituisce la base per la morale, che a sua volta tende a fini razionali e quindi universali, nei quali trova il suo particolare carattere di attività morale.
Il C. caratterizza come non rilevanti, per la riflessione filosofica, tutte le suddivisioni dell'espressione, secondo forme e contenuti specifici dell'arte, essendo questi determinanti e adatti solo all'uso empirico. Per tutti i campi è valida l'osservazione di base che lo sviluppo di attività costituisce autonoma realizzazione di valore. Quindi a questi campi vengono attribuiti il bello, il vero, l'utile e il buono come corrispettive realizzazioni di valore, e questi stanno a loro volta fra loro, nello stesso rapporto dei quattro campi, nella su menzionata relazione. "I quattro valori s'implicano regressivamente per la loro concretezza: il vero non può star senza il bello, l'utile senza entrambi, e il buono senza i tre precedenti" (Tesi..., p. 45). I contrari di questi valori, per esempio il brutto, non hanno una propria esistenza indipendente, ma consistono piuttosto nella non completa realizzazione dell'attività cominciata, nel persistere di elementi di passività.
Il C. riconduce in seguito la storia, in quanto rappresentazione dell'individuale, al campo dell'arte come espressione dell'individuale e considera, come suo momento differenziale , la sua subordinazione al criterio di realtà. Egli rifiuta, come una contraddizione in sé, una filosofia della storia, perché per lui storia significa concretezza e individualità, mentre la filosofia tende ai concetti, alla conoscenza dell'universale.
Nelle Tesi di un'estetica, e successivamente in forma più estesa nell'Estetica, il C. attribuisce alla storia determinate funzioni anche in rapporto al lavoro retrospettivo sulle espressioni artistiche. La storia deve far presenti le condizioni originarie di un'espressione artistica, e così rendere possibile e facilitare la riproduzione dell'espressione originaria, in base alle sue "estrinsecazioni" attuate nella attività pratica dell'artista. Se la riproduzione dell'espressione è riuscita, allora è compito in particolare della storia della letteratura rappresentare l'espressione nella sua storicità, e cioè nella sua posizione all'interno di un determinato circolo evolutivo dell'espressione